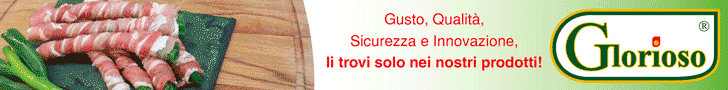Due sorelle di 13 e 20 anni; una 19enne; e poi due ragazzine di 10 e 12 anni.
E l’elenco potrebbe continuare ancora: loro sono le vittime delle violenze sessuali che abbiamo dovuto raccontare in questo scorcio di fine estate. Violenze che riguardano il nord come il sud, est come ovest.
Perché qualcuno in questo momento sta dicendo – e sta scrivendo sui social – che queste cose riguardano più che altro il sud o i luoghi disagiati.
Di disagiato c’è solo chi commette la violenza: e questo, purtroppo, non ha ceto sociale, non ha ricchezza o povertà. Anzi, una povertà ce l’ha: quella educativa ed emozionale.
Già, perché i ragazzi di oggi sono incapaci di provare emozioni ritenendo che tutta la “realtà” sia racchiusa dentro un cellulare con il quale conoscono persone, filmano ciò che fanno, creano gruppi.
Poi però senza quel cellulare non riescono a stare, a socializzare, a vivere. Prova ne sia che uno degli arrestati per la violenza di gruppo a Palermo mentre era nella comunità – in cui era stato condotto in un primo momento – continuava a cercare followers su TikTok esaltando il fatto che molte persone avevano cominciato a seguirlo da quando avevano saputo che era uno dei protagonisti.
Proprio sulla parola protagonisti gira, a mio avviso, parecchio di queste vicende: abbiamo bisogno di sentirci protagonisti e poco importa se l’azione che compiamo è negativa, comunque si sta parlando di noi.
E nel ‘noi’ dobbiamo mettere anche tutti i followers che in maniera spasmodica hanno cominciato a cercare sui social e sui motori di ricerca i nomi delle vittime, dei violentatori: ma sopratutto hanno cominciato a cercare – nel caso della violenza di Palermo – il video di quanto accaduto. Quel ‘noi’ che nei salotti si indigna per quanto accade nella società di oggi ma che poi nel privato ama spiare dal buco della serratura. Con il risultato che se questi mostri hanno violentato la ragazza, NOI l’abbiamo offesa ancora di più andando a cercare cosa è accaduto per soddisfare la curiosità morbosa.
Diventando complici di un sistema che porta a una vittimizzazione secondaria, della quale però si parla poco e sulla quale si riflette ancora meno.
Verso la vittima, in alcuni casi, si punta un dito contro, la si insulta: sempre nel caso della violenza di Palermo, la 19enne è stata costretta ad andare via dalla sua città, a doversi difendere da accuse e insulti. L’abbiamo “violentata” una seconda volta. E ci metto in mezzo tutti, soprattutto molti dei quali in questi giorni stanno condividendo frasi di sostegno sui social e poi, nel privato, offendono la propria compagna, le mancano di rispetto, invitano la propria figlia a non mettere la minigonna, a non dare ‘confidenza’, a non istigare i maschi.
Un po’ come gli stalker o chi si macchia di violenza di genere e poi il 25 novembre mette una foto di scarpe rosse o partecipa ai cortei.
Siamo nell’epoca delle contraddizioni in cui l’unica cosa che si dovrebbe fare è posare i cellulari, guardarsi negli occhi e tornare a parlare. Perché di comunicare non abbiamo mai smesso – “non si può non comunicare” – ma abbiamo comunicato odio, violenza, indifferenza. È arrivato il momento di tirare il freno a mano e di parlare di emozioni, di sedersi su una panchina, di osservare e soprattutto di intervenire. Facciamolo per noi stessi per vivere meglio. E facciamolo anche per gli altri.
Altrimenti di articoli come quello del New York Times su cosa succede in Italia ne arriveranno moltissimi e non ci facciamo certo una bella figura.
P.S. A onor del vero, non che nella democratica America vada meglio se una donna di colore e incinta viene uccisa dalla polizia. Ma questo è un altro capitolo sul quale magari presto scriveremo un’altra riflessione
- Pubblicità -