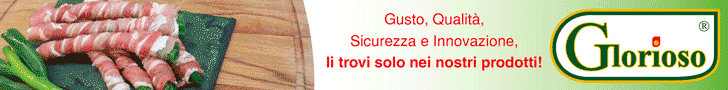All’indomani della “seconda guerra di mafia“, quando furono ammazzate per strada quasi mille persone, in agguati e imboscate organizzate con tecniche militari, Palermo era una città terrorizzata e blindata.
In quel conflitto interno alla mafia, esploso a causa di una situazione di instabilità interna scossa da grossissimi interessi legati al traffico internazionale di droga e armi, non caddero sotto i colpi dei kalashnikov solo i membri dell’organizzazione criminale, parenti e fiancheggiatori, ma anche magistrati, giornalisti, sindacalisti, politici, uomini delle forze dell’ordine.
In città allora, già nelle prime ore del pomeriggio, si respirava un’aria di stato d’assedio, di coprifuoco: circolava nelle strade solo chi doveva recarsi al lavoro, chi doveva rientrare nella propria abitazione dopo un giorno di fatica e chi era obbligato a fare qualche acquisto assolutamente essenziale.
Per il resto anche nei quartieri del centro non circolava anima viva.
Fu in quel contesto, caratterizzato da un impegno eccezionale di magistrati e forze dell’ordine contro lo strapotere delle organizzazioni mafiose, che in un giorno dell’autunno del 1985, esattamente il 25 novembre, morirono due ragazzi, investiti da una delle macchine di scorta del giudice Borsellino, poi trucidato nella strage di Via D’Amelio.
I due ragazzi, Biagio Siciliano, di 14 anni e Giuditta Milella, di 17 anni, rimasero uccisi insieme ai loro sogni in via Libertà, mentre insieme ad una cinquantina di studenti del liceo classico Giovanni Meli erano in attesa alla fermata dell’autobus.
Biagio morì all’istante, Giuditta, figlia di un funzionario di polizia, morì dopo una settimana di agonia in ospedale.
Lo stesso giorno di quel terribile evento, che aveva troncato nel fiore degli anni la vita di due ragazzini e ferito in modo non grave altri venti studenti, si scatenò una polemica sull’attribuzione delle scorte, sull’utilizzo delle auto blindate e sul fatto che sfrecciassero a grande velocità per le strade cittadine. Una polemica che sfociò financo nella richiesta di allontanare, di sfrattare alcuni magistrati dai palazzi in cui abitavano.
Un magistrato in quei giorni, particolarmente colpito da quella polemica, dichiarò: “Vorremmo tanto essere cittadini come gli altri, liberi di muoverci a piacimento e non prigionieri di auto blindate della scorta. Questo è un prezzo inevitabile da pagare per noi e per la città“.
Rispetto a quella tragedia che aveva colpito così duramente le famiglie di Biagio e Giuditta, lo stesso giudice Borsellino dichiarò: “Quel che è accaduto è una conseguenza delle condizioni in cui si vive in questa città, condizioni create dalla mafia“.
Riandare con la memoria in quegli anni, quando erano in trincea magistrati e forze dell’ordine, ma anche, seppure in misura minore, esponenti di partito, sindacati e di associazione di categoria, significa riaprire una ferita profonda che non si è mai rimarginata.
Non si è rimarginata nel cuore delle famiglie e degli amici di quelle due vittime innocenti, ma neppure in chi ha vissuto quegli anni terribili che sconvolsero l’intera nazione, in chi era impegnato a tenere il fronte dell’impegno sociale e politico.
Pippo Glorioso, allora segretario della CNA del capoluogo siciliano, che interpelliamo mentre discute di memoria e passione civile, di paura e coraggio e mentre definisce con i suoi collaboratori la partecipazione della CNA alla commemorazione di Giuditta e Biagio che si terrà nei pressi di piazza Croci alle 9.30, davanti alla targa ; così ricorda quel periodo nefasto e quella tragedia: “Negli anni della seconda guerra di mafia che vide l’affermarsi del clan dei corleonesi (la prima fu quella esplosa a metà degli anni sessanta in coincidenza con il sacco di Palermo e con la strage di viale Lazio) in città si sparava nelle strade, nelle piazze, nelle campagne , si facevano sparire le persone con il metodo della lupara bianca o si scioglievano nell’acido, nessuno si sentiva al sicuro. Per paura di beccarsi qualche pallottola vagante gli impiegati degli apparati pubblici non mettevano la testa fuori dagli uffici neppure per andare al bar a bere un caffè. Io, ma come me tutti quelli che erano impegnati nei partiti, nei sindacati e nelle associazioni di categoria quando per esigenze organizzative dovevo spostarmi nei comuni della provincia o tra un quartiere e l’altro per partecipare a riunioni o incontri di lavoro, ricordo mi muovevo con estrema cautela e adottavo tutte le precauzioni del caso. Questo a prescindere del fatto di essere bersaglio o meno di qualche cosca, adottavamo in tanti queste precauzioni per evitare di trovarci in mezzo a qualche sparatoria, a qualche scontro tra cosche rivali, per evitare cioè di diventare vittime innocenti. Ecco, la morte di Giuditta e di Biagio si inquadra in quel contesto di terrore e di paura che coinvolgeva tutti, anche chi era preposto alla sicurezza delle personalità maggiormente esposti al fuoco della mafia”.
Chi non ha vissuto quegli anni magari pensa, leggendo questa nota: “ma è mai possibile che tutto questo sia accaduto davvero?”
Si, è accaduto davvero.
È accaduto che prima e dopo il martirio di Biagio e Giuditta sono caduti sul fronte della lotta alla mafia e della salvaguardia della democrazia magistrati, poliziotti, politici, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, giovani e imprenditori come Peppino Impastato e Libero Grassi che sacrificarono la loro vita per dire no ai soprusi, alle prepotenze, alla mafia.
Salvatore Bonura