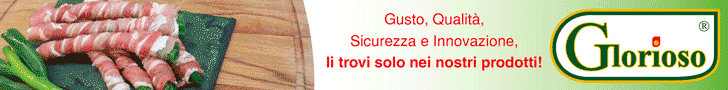Come purtroppo tutti sappiamo giorno 13 agosto è venuto a mancare Gino Strada. Noi scegliamo di ricordarlo grazie a questo comunicato stampa di “Le Scienze” – la cui riproduzione è espressamente consentita – in cui il medico racconta (mediante un’intervista di qualche anno fa) la sua storia e quella delle battaglie combattute con Emergency per un bene chiamato salute.
Sei milioni di persone curate. In quasi ogni continente, e da qualche anno anche in Italia. Un sostegno decisivo nel tenere in piedi la sanità di intere nazioni come l’Afghanistan. Centri d’eccellenza gratuiti dove nessuno se li sarebbe aspettati (e non tutti sono contenti che ci siano). Sono stati vent’anni tumultuosi, quelli di Emergency. Di attività sul campo e sui media, di battaglie e di polemiche, di lotte contro traumi e germi ma anche contro le carte bollate. Fra interventi pianificati con cura e quelli in cui ci si è ritrovati trascinati a forza, come l’emergenza Ebola in Sierra Leone. Da dove Gino Strada, anima e volto dell’associazione, ci racconta di questi vent’anni e del futuro.
Come vi siete trovati a occuparvi di Ebola?
Ce ne occupiamo da mesi, non dico controvoglia ma di necessità. Da 13 anni qui a Goderich, nei dintorni della capitale Freetown, abbiamo un ospedale chirurgico e pediatrico. Quando è scoppiata l’epidemia continuavano ad arrivare bambini con la febbre. Ma a quel punto dovevamo chiederci: è un bimbo con la dissenteria o la malaria o uno che ha l’Ebola? Dovevamo evitare nel modo più assoluto che un paziente con Ebola entrasse nel centro chirurgico o pediatrico, altrimenti avremmo dovuto chiuderli. E per molte settimane sono stati gli unici ospedali aperti a Freetown.
A causa di Ebola?
Certo. Una parte del personale degli ospedali pubblici si è infettata, gli altri hanno smesso di andare al lavoro e di fatto gli ospedali hanno chiuso. Per evitare che succedesse a noi abbiamo realizzato una tenda d’isolamento fuori dall’ospedale, dove individuare i casi sospetti e verificarli cercando il virus con la PCR. Poi il Ministero della Sanità ci ha chiesto di allestire un centro per Ebola in un’altra località vicina, Lakka. Il nuovo centro è operativo da metà settembre con 22 letti, ed è sempre pieno; trovare un posto per i malati è sempre un problema. A Goderich ne stiamo preparando un altro da 100 letti, costruito dagli ingegneri militari inglesi su mandato della cooperazione britannica, che ne sosterrà anche finanziariamente la gestione. L’apertura è prevista a dicembre. Lo staff medico-infermieristico sarà sia locale sia internazionale.
In assenza di terapie specifiche, che cosa offrite ai malati?
Qui in Sierra Leone ci sono di fatto due pratiche. A noi non va di organizzare mere strutture di isolamento e contenimento della malattia, come sono molte: vogliamo realizzare strutture di trattamento. Cerchiamo di ottimizzare via via la migliore cura di supporto: trattamento dei sintomi, infusioni endovenose in aggiunta alla reidratazione orale, profilassi antibiotica, se necessario trasfusioni, monitoraggio dei parametri vitali, esami ematochimici, della funzione renale ed epatica, della coagulazione e via dicendo.
Ma intanto vi state preparando a un nuovo studio clinico.
Sì, vorremmo usare l’amiodarone. È un antiaritmico di ampio uso, e in vitro, alle concentrazioni che raggiunge di norma nel siero umano, ha dimostrato una forte capacità di inibire l’ingresso del virus in molti tipi di cellule, agendo sia sulla pompa ionica sia sugli organuli di trasporto che il virus usa per entrare. Per ora lo stiamo usando in modo compassionevole. Ma per capire se funziona davvero nel nuovo centro vogliamo avviare un trial randomizzato a due bracci: confronteremo chi riceve solo le migliori cure di supporto e chi riceve anche l’amiodarone. Il trattamento dura dieci giorni.
Avete bruciato le tappe, dalle colture cellulari ai malati…
Sì, ma in linea con le raccomandazioni dell’Organizzaione mondiale della Sanità. Non è un farmaco sperimentale ma in uso da decenni, di cui sappiamo già tutto: come funziona, che effetti collaterali può dare, come rilevarli (in soli dieci giorni dovrebbero essere modesti). Ci aspettiamo di sapere se può essere non la soluzione, ma una delle cure possibili. E l’unico metodo che ci sentiamo di sostenere sono gli studi randomizzati; anche se su Lancet sono stati invocati studi di altro tipo, crediamo che metodi meno rigorosi non generino una conoscenza adeguata.
Quando si sapranno i risultati?
Lo studio sarà effettuato in collaborazione con l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e l’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ed è stato approvato dal comitato etico provinciale di Reggio Emilia. Il campione per ora è fissato in circa 150 casi, con due analisi ad interim: quando saremo a un terzo e a due terzi dei pazienti. Un comitato di valutazione deciderà se continuarlo, interromperlo per gli eventi avversi o viceversa concluderlo e dare l’amiodarone a tutti perché i benefici sono già evidenti. Il trial inoltre ci obbliga a standardizzare e ottimizzare anche la migliore cura di supporto, che di per sé potrebbe già ridurre molto la mortalità. Le stime, pur discordanti, collocano la mortalità per questa epidemia poco sopra il 70 per cento. Noi vedremo come andrà nei due bracci e trarremo le conclusioni.
Parlando di Emergency, dopo vent’anni vi aspettavate un successo simile?
No, nessuno se lo aspettava. È successo perché abbiamo lavorato con passione e professionalità.
Come vi è venuto in mente di fondarla?
Io e altri colleghi avevamo lavorato per anni come chirurghi in vari conflitti, e ci siamo resi conto che gli aiuti alle popolazioni erano insufficienti. Così ci siamo detti che una mano in più non fa mai male. Poi pian piano abbiamo costruito il nostro modo di lavorare, che intende la pratica medica come il dare corpo a un diritto umano universale, il diritto a essere curati. Ma se è un diritto universale non può arrivare fino alla TAC o alla risonanza da noi in Italia e fermarsi a quattro vaccini e due antibiotici in Africa. Questo è stato un grande momento di sviluppo nel modo di gestire le nostre strutture.
Si riferisce all’idea di creare centri d’eccellenza in Africa?
Anche. Uno degli ultimi ospedali che abbiamo aperto è il Centro Salam di cardiochirurgia, inaugurato nel 2007 a Khartoum, in Sudan, che per il suo livello ha sconvolto chiunque sia venuto a vederlo. Certo, è una goccia nel mare di pazienti. Oltre alle cardiopatie congenite, in Africa ci sono cinque milioni di persone con malattia reumatica avanzata bisognose di chirurgia, con 300.000 morti all’anno. Il nostro è l’unico ospedale nel continente che fornisce cardiochirurgia di alto livello del tutto gratuita. Facciamo 800-1000 interventi all’anno, e al personale chiediamo anche di insegnare: abbiamo già iniziato a formare sul posto gli infermieri e ora stiamo cominciando con i medici.
La scelta di destinare le risorse a un centro specialistico ha sollevato molte obiezioni.
Molte critiche vengono dai superesperti che decidono da Roma che cosa serve ai sudanesi e senza neanche averli interpellati. Noi ci siamo consultati prima, e nel 2010 su nostra iniziativa è nata la Rete sanitaria d’eccellenza in Africa, e le autorità di 11 paesi africani hanno individuato il Centro Salam come modello da replicare.
Più in generale, avete aiutato anche a sviluppare i sistemi sanitari locali?
Un esempio è l’Afghanistan, dove si sono specializzati e lavorano con noi i primi tre specialisti in traumatologia e chirurgia di guerra del paese. Abbiamo messo in piedi una maternità dove formiamo ostetriche e ginecologhe in collaborazione con il Ministero della Sanità e vengono a partorire donne da molte regioni, 45 cliniche e posti di pronto soccorso che fanno da cliniche di base e inviano i pazienti ai centri medici e chirurgici. Insomma, abbiamo costruito la prima intelaiatura di un sistema sanitario afghano, almeno per chirurgia d’emergenza, traumatologia e ostetricia-ginecologia.
Ha avuto anche delusioni?
La maggiore frustrazione è nel cercare di lavorare con le istituzioni, soprattutto italiane. Anche adesso parecchi medici sarebbero pronti a venire dall’Italia in Sierra Leone ma sono bloccati dalla burocrazia. Non solo passi un sacco di tempo in riunioni e scartoffie, ma devi scontrarti con l’idea ormai dominante che la salute delle persone sia solo un bene commerciale. Io continuo a credere che gli ospedali debbano essere luoghi ospitali, e che medici e infermieri debbano occuparsi della salute del paziente, non della salute dei bilanci aziendali.
Non ha mai pensato “chi me lo ha fatto fare” e avuto voglia di mollare tutto, almeno per un po’?
È chiaro che ogni tanto te lo chiedi. Però in ospedale la risposta ce l’hai sempre davanti agli occhi: te l’ha fatto fare Mohamed, Ibrahim, Hawa… E se pensi che essere curati non sia un’opzione che tu offri ma un loro diritto, allora ti comporti di conseguenza.
Per il futuro che novità avete in programma?
Stiamo preparando un centro d’eccellenza di chirurgia pediatrica in Uganda. Come per la cardiochirurgia, in Africa non ce n’è uno di alto livello e gratuito. Il progetto è di Renzo Piano, il cantiere ha appena aperto, e appena usciti dall’emergenza Ebola ci concentreremo sulla ricerca delle risorse per costruirlo. Speriamo sia pronto in un paio d’anni.
Mi ha sorpreso quando qualche anno fa avete iniziato ad aprire centri in Italia…
Ha sorpreso anche noi: è l’ultima cosa che ci saremmo aspettati quando siamo nati. E invece apriamo strutture di medicina generale, orientamento sociosanitario, ginecologia, odontoiatria, cardiologia. All’inizio le pensavamo per i migranti, ma ora sempre più italiani si rivolgono a noi. L’ultimo rapporto CENSIS parla di dieci milioni di italiani che non possono permettersi di curarsi a dovere. Quindi ci sono bisogni importanti anche in Italia, purtroppo. Probabilmente apriremo altri centri, anche più complessi.
Ma non vi stancate di fare i pompieri, di risolvere guai creati da altri e su cui altri dovrebbero intervenire?
È il vecchio discorso della sussidiarietà, ti sostituisci a quello che dovrebbero fare Stati e governi. Ed è vero. Ma il problema è che il signor nome-e-cognome, che ha bisogno di cure oggi, non può aspettare che facciano le riforme o che spendano i soldi nella sanità anziché negli F35. I suoi bisogni o sono soddisfatti oggi o non lo sono più. Allora dico sempre che il nostro intervento non è la soluzione del problema, ma è la soluzione dei problemi di quelle persone che si rivolgono a noi. Finora sei milioni nel mondo.
Mai pensato invece di passare all’azione diretta in politica?
Ai politici che mi hanno ventilato l’idea ho sempre risposto che da ministro della Sanità avrei un programma molto semplice: eliminerei il profitto dalla sanità. Oggi il bilancio sanitario italiano è circa 105 miliardi di euro all’anno e di questi 30 miliardi vanno in profitti. Ecco: riportiamo a casa quei 30 miliardi e investiamoli nella salute delle persone. Dopo questa risposta, nessuno mi ha mai fatto una proposta seria.
Di tutto quanto avete fatto in questi vent’anni di che cosa è più contento e orgoglioso?
Sono contento che in vent’anni siamo riusciti a curare più di sei milioni di persone, e a curarle bene. Rispetto ai bisogni è una goccia, ma sono convinto che sia stato meglio che sia esistita e che continui a esistere. Se ciascuno fa il suo pezzettino, alla fine ci troviamo in un mondo più bello senza neanche accorgercene.
——————————————————————————————————————————————————
Nato nel 1948 a Sesto San Giovanni, vicino a Milano, Gino Strada si laurea in medicina e si specializza in chirurgia d’urgenza. Dopo aver lavorato per anni come cardiochirurgo, si orienta verso la cura delle vittime di guerra e dal 1989 lavora con il Comitato internazionale della Croce Rossa in vari teatri di conflitti, tra cui Pakistan, Perù, Etiopia, Afghanistan ed ex Jugoslavia. Nel 1994 fonda Emergency con alcuni colleghi e la moglie Teresa Sarti (presidente fino alla morte nel 2009), per curare le vittime dei conflitti, con un particolare impegno contro le mine antiuomo. Al lavoro affianca un impegno per la pace e i diritti umani