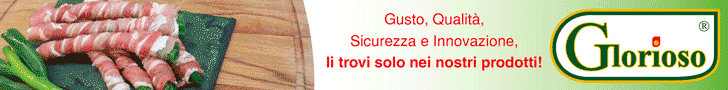Studi sul genoma hanno permesso di scoprire fattori di rischio genetico per la malattia, che potranno forse indirizzare i ricercatori verso la definizione di possibili cure
Dallo scorso maggio, diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno passando al setaccio i genomi di oltre 100.000 persone affette da COVID-19, nella speranza di trovare indicazioni genetiche su quali siano i pazienti che saranno colpiti in modo più grave dal contagio del virus SARS-CoV-2. Da questo lavoro sono emerse una dozzina di varianti genetiche che presentano una forte associazione statistica con la probabilità che il soggetto sviluppi COVID-19 e si ammali in forma grave, come riferiscono i ricercatori in un’analisi riepilogativa pubblicata di recente su “Nature”.
“In effetti c’erano parecchie varianti genetiche molto comuni che avevano un ruolo di grande rilievo in COVID-19”, afferma Guillaume Butler-Laporte, infettivologo ed epidemiologo genetico alla McGill University di Montreal, in Canada. “Direi che non ci aspettavamo di trovarle in modo così evidente.”
I gruppi collaborano allo studio in modo non strettamente coordinato, includono sia laboratori accademici che aziende private, come le statunitensi 23andMe e AncestryDNA, e hanno reso noti i loro risultati in modo continuativo durante lo scorso anno. Nell’insieme l’iniziativa si chiama COVID-19 Host Genetics Initiative (HGI) e a marzo ha presentato la prima analisi riepilogativa (che ha messo insieme 46 studi diversi per un totale, nel momento in cui è stata presentata l’analisi, di quasi 50.000 soggetti affetti da COVID-19) sul server di preprint medRxiv.
Le associazioni genetiche individuate comportano un aumento di rischio relativamente ridotto, anche se in alcuni casi paragonabile a quello causato da fattori di rischio come obesità, diabete e altre patologie pregresse.
Queste scoperte possono però fare luce sui meccanismi biologici della malattia e suggerire quali farmaci sperimentare, afferma Kenneth Baillie, medico di terapia intensiva e genetista all’Università di Edimburgo, nel Regno Unito. In altri studi sono state individuate anche mutazioni genetiche rare (diversamente da quelle piuttosto comuni elencate nell’ultimo studio di HGI) che potrebbero spiegare anche le cause profonde della forma grave della malattia.
Non tutti sono convinti che gli studi genetici possano dare informazioni immediate. “Iniziamo ad avere una mappa genetica abbastanza buona”, afferma Julian Knight, genetista umano all’Università di Oxford, nel Regno Unito. “Per arrivare da qui al punto in cui avremo buoni bersagli farmacologici o una comprensione della variabilità della malattia, dobbiamo ancora fare passi enormi.” Questo, secondo Knight, è un problema comune per la ricerca che prova a collegare variazioni comuni del genoma con il rischio di contrarre malattie complesse.
Kári Stefánsson, direttore esecutivo di deCODE Genetics a Reykjavik, in Islanda, e membro di HGI, non ritiene che il lavoro di ricerca di mutazioni genetiche abbia dato particolari frutti, almeno per il momento. Però, continua Stefánsson, “credo che sia importantissimo approfondirne il maggior numero possibile. Si potrebbe scoprire un meccanismo di importanza cruciale”.
Anche se i genetisti non hanno ancora tutte le risposte, si sono mossi in modo estremamente rapido per sbrogliare la matassa delle associazioni genetiche con COVID-19, sostiene Brent Richards, genetista ed endocrinologo alla McGill University che fa parte di HGI. “Chi lavora sulla genetica umana non ha passato molto tempo a dormire, quest’anno”, afferma.
Mutazioni genetiche per COVID-19
HGI non funzionava tanto come un consorzio, concentrato su un singolo progetto che univa tutti i partecipanti, quanto come uno sportello a cui rivolgersi per collaborazioni, sostegno e consigli. I gruppi di ricerca erano liberi di pubblicare i propri studi, mentre allo stesso tempo contribuivano anche a lavori che mettevano insieme i risultati delle ricerche dei singoli membri. “Si trattava di creare un posto in cui le persone si sentissero a proprio agio le une con le altre e potessero lavorare insieme”, racconta Andrea Ganna, statistico genetico e cofondatore di HGI assieme al genetista Mark Daly; entrambi lavorano all’Università di Helsinki e al Broad Institute di Cambridge, in Massachusetts.
Ganna è specializzato in studi di associazione genome–wide (GWAS, genome–wide association studies), che sono il pane quotidiano dell’epidemiologia genetica. Questi studi esaminano centinaia di migliaia di variazioni di una sola lettera nel DNA, variazioni che sono abbastanza comuni nella popolazione e presenti in un gran numero di persone, per capire se siano più diffuse nei soggetti con una particolare malattia o un particolare tratto. Era inevitabile che qualcuno usasse i GWAS su COVID-19, secondo Ganna.
Una variante genomica identificata dal gruppo di ricerca di Baillie e confermata da altri lavori di HGI è vicina a una famiglia di geni antivirali chiamata OAS (oligoadenilato-sintetasi); questi geni attivano enzimi che distruggono l’RNA virale. Alcuni studi di HGI dimostrano che una variante che causa una riduzione dei livelli dell’enzima OAS1 in circolazione nei polmoni aumenta il rischio di contagio, ospedalizzazione e malattia acuta. La maggior parte dei coronavirus combatte questa forma di protezione usando proteine chiamate PDE, o fosfodiesterasi, ma SARS-CoV-2 non produce PDE. “Perciò questo potrebbe rappresentare un tallone d’Achille”, spiega Richards, che dice di conoscere aziende farmaceutiche che stanno lavorando a questo bersaglio farmacologico, ma non vuole rivelare ulteriori dettagli. Sulla base delle associazioni genetiche, si prevede che alcuni farmaci chiamati inibitori della fosfodiesterasi-12 possano amplificare le difese antivirali naturali, sostiene Baillie.
Un’altra variante individuata dal gruppo di ricerca di Baillie e confermata da altri studi GWAS su COVID-19 è vicina a un gene che codifica parte di un recettore cellulare di molecole chiamate interferoni, noti per la loro capacità di amplificare la risposta immunitaria ai virus. Dato questo suo ruolo antivirale, un tipo di interferone era già stato sottoposto a sperimentazione clinica prima che venisse alla luce questa associazione genetica.
Era stato uno dei primi farmaci inclusi nello studio clinico sulle terapie anti COVID-19 chiamato “Solidarity”, finanziato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ma non aveva avuto effetti benefici sui pazienti. È possibile che la previsione genetica fosse erronea, sostiene Baillie, ma è anche possibile che l’interferone debba essere somministrato più precocemente nel decorso della malattia, oppure in un modo diverso rispetto alle iniezioni sottocutanee o endovenose usate per i partecipanti alla sperimentazione Solidarity.
Baillie spiega anche che oggi si usano altre associazioni genetiche per decidere le terapie a cui dare priorità. Un esempio è l’apprezzatissima sperimentazione britannica RECOVERY, con la quale, come è noto, nei pazienti affetti da COVID-19 in forma grave sono stati dimostrati i benefici di uno steroide comune. Quello studio usa anche dati genetici per arrivare alla scelta dei farmaci da sperimentare; tra questi si contano un farmaco contro l’artrite reumatoide chiamato baricitinib e una terapia contro la psoriasi e la sclerosi multipla chiamata dimetilfumarato, afferma Baillie, che partecipa a quel lavoro.
Baricitinib inibisce la proteina codificata dal gene TYK2, che è stato associato con la forma potenzialmente letale di COVID-19. La relazione tra l’attività del gene TYK2 e il rischio di COVID-19 in forma grave non è documentata in modo netto ed evidente negli studi genetici, “ma è stata un’importante fonte aggiuntiva a sostegno di questa idea”, commenta Baillie. Il dimetilfumarato è stato incluso nella sperimentazione soprattutto perché se ne conosce la capacità di alleviare il processo infiammatorio che si presenta nella forma grave di COVID-19, ma i collegamenti genetici sono stati un motivo in più per inserirlo nella sperimentazione RECOVERY, afferma Baillie.
Gli studi GWAS, però, sono noti anche perché spesso danno risultati confusi. È successo anche con COVID-19: l’associazione più forte tra qualsiasi variante genetica e la forma grave della malattia è localizzata in una regione poco studiata del cromosoma 3. “Ancora non sappiamo bene, tutti noi della comunità scientifica, perché sia così importante”, commenta Butler-Laporte. Questa regione del cromosoma 3 include diversi geni coinvolti nelle segnalazioni al sistema immunitario, nella biologia polmonare e in altri meccanismi plausibili. Però non è chiaro quale di questi geni spieghi l’associazione con COVID-19.
Gli individui con questa variante hanno quasi il doppio di probabilità di finire in ospedale per COVID-19 rispetto agli altri. Uno studio condotto da Richards, Ganna e Tomoko Nakanishi, genetista e pneumologa alla McGill University, ha rilevato che, nelle persone sotto i 60 anni, questa variante aumenta la probabilità di contrarre COVID-19 in forma grave o di morirne almeno quanto altri fattori di rischio come il diabete, l’obesità e la broncopneumopatia cronica ostruttiva, se non di più.
Punteggi di rischio
Date queste associazioni, alcuni ricercatori stanno provando a capire se i legami genetici scoperti negli studi GWAS si possano usare per prevedere il rischio del singolo paziente di essere contagiato da SARS-CoV-2 in forma potenzialmente letale. I punteggi di rischio, che includono le associazioni scoperte dagli studi GWAS, sono stati usati per misurare il rischio del singolo individuo per condizioni come il diabete di tipo II, diversi tipi di cancro e le malattie cardiovascolari.
Tuttavia, non è chiaro se questo tipo di approccio possa funzionare anche per COVID-19, né, a dire il vero, se sia necessario, data la disponibilità dei vaccini. A giugno Genetic Technologies, un’azienda di Fitzroy, in Australia, ha lanciato un test che costa 175 dollari statunitensi e promette di prevedere il rischio di sviluppare COVID-19 in forma grave per il singolo individuo. Però questo strumento tiene conto anche di età, sesso e condizioni di salute, tutti fattori che aumentano significativamente la capacità predittiva delle associazioni individuate dagli studi GWAS.
Il direttore scientifico di Genetic Technologies, Richard Allman, afferma che il test, sviluppato e convalidato usando dati provenienti dalla banca dati UK Biobank, potrebbe rivelarsi utile soprattutto per le persone di mezz’età. La maggior parte di loro ha un rischio relativamente basso di contrarre la forma grave di COVID-19, ma il test potrebbe identificare quei rari casi di individui per i quali la probabilità di sviluppare l’infezione in forma potenzialmente letale è molto più alta (oppure molto più bassa). Attualmente questo test è disponibile solo negli Stati Uniti, importato da un’azienda chiamata Infinity BiologiX con sede a Piscataway, nel New Jersey, e solo dopo aver consultato un operatore sanitario. Genetic Technologies è in trattativa con aziende interessate a offrirlo ai propri dipendenti, afferma Allman, che però sostiene di non avere a disposizione i dati di vendita.
Nakanishi, Richards e Ganna affermano che non è chiaro se il test sia stato convalidato a un livello sufficiente per garantirne l’affidabilità, ma ciò non significa che questo tipo di strumento non possa rivelarsi utile come ulteriore motivazione per spingere le persone ad alto rischio a vaccinarsi. “Potrebbe convincere alcuni di coloro che tentennano perché sono preoccupati [dal vaccino]”, aggiunge Gillian Dite, biostatistica di Genetic Technologies.
Gli studi genetici su COVID-19, come quelli sulla maggior parte delle altre malattie, sono stati effettuati in modo preponderante tra persone di ascendenza europea. Questo è un problema, spiega Knight, perché COVID-19 riguarda il mondo intero e in paesi come Stati Uniti e Regno Unito si presenta in percentuali elevate nei gruppi etnici di minoranza. “Dobbiamo davvero investire nella genetica in quelle fasce di popolazione.”
Diversificare gli studi genetici può non solo aumentare la comprensione delle varianti di rischio identificate nella popolazione di origine europea, ma anche identificarne altre negli altri gruppi. Uno studio GWAS su oltre 2000 persone ricoverate con COVID-19 in Giappone ha identificato molte delle varianti segnalate negli studi su popolazioni europee, ma anche il gene del sistema immunitario DOCK2, coinvolto nella produzione di interferoni, che non era stato individuato in altri studi. La variante di DOCK2 che aumenta il rischio di COVID-19 era relativamente comune tra le persone dell’Asia orientale, ma molto rara in individui di ascendenza europea, sud-asiatica e africana. “Questo sottolinea l’importanza di aumentare la diversità dei soggetti quando studiamo la genetica degli organismi ospiti con riferimento a COVID-19”, afferma il direttore dello studio, Yukinori Okada, statistico genetico all’Università di Osaka, in Giappone.
Mutazioni rare
Alcuni ricercatori ritengono che l’approccio degli studi GWAS, che ha individuato varianti comuni che aumentano di poco il rischio per il singolo individuo, sia meno fruttuoso rispetto alla scoperta di mutazioni molto più rare che potrebbero spiegare perché alcune persone, per il resto sane, si ritrovino in terapia intensiva con COVID-19.
La pensa così Jean-Laurent Casanova, genetista della Rockefeller University a New York City e condirettore di un consorzio chiamato COVID Human Genetic Effort. A settembre 2020 questo consorzio ha riferito di aver individuato in soggetti colpiti da COVID-19 in forma grave alcune mutazioni che inibiscono alcuni geni coinvolti in una forte risposta antivirale, l’immunità da interferoni di tipo I. (Uno dei geni in cui il consorzio ha individuato mutazioni, IFNAR2, che codifica una subunità di un recettore di interferoni, era stato segnalato anche da diversi studi GWAS.)
Le mutazioni identificate dal gruppo di Casanova erano rare, ma in uno studio di follow up i ricercatori hanno scoperto che il 10 per cento degli individui colpiti da COVID-19 in forma potenzialmente letale produceva anticorpi che inibiscono gli interferoni di tipo I, imitando gli effetti delle mutazioni genetiche. Casanova afferma che il suo gruppo ha cercato quegli anticorpi solo dopo aver identificato la mutazione genetica, sottolineando la forza di questo approccio nel suggerire nuove direzioni di ricerca. “In pratica quello che abbiamo scoperto è un meccanismo della polmonite grave da COVID-19”, commenta.
Le mutazioni rare con conseguenze profonde sono “un’ottima torcia da usare” per scoprire i meccanismi delle malattie, sostiene Akiko Iwasaki, immunologa alla Yale University a New Haven, in Connecticut, il cui gruppo di ricerca sta studiando il ruolo degli “autoanticorpi” che attaccano le difese immunitarie del corpo stesso, nella forma grave di COVID-19. Gli effetti delle varianti comuni identificate negli studi GWAS saranno pure più discreti, aggiunge, ma il metodo imparziale con cui esse sono state identificate implica che le mutazioni possono dare maggiore credibilità a scoperte provenienti da altre discipline, come l’immunologia. “Spiega alcune delle cose che osserviamo”, commenta Iwasaki. “Mi piace molto questo aspetto.”
Richards fa parte di un gruppo di ricerca che cerca di replicare la scoperta genetica fatta da Casanova, anche se finora non ha avuto successo. Con i suoi colleghi ha appurato che le mutazioni in 13 geni degli interferoni di tipo I non erano più comuni nelle quasi 2000 persone con COVID-19 che nel gruppo di controllo, composto da soggetti nei quali non era stato rilevato alcun contagio; questo risultato riflette le stesse conclusioni a cui era giunta un’analisi condotta dai ricercatori dell’azienda biotecnologica Regeneron di Tarrytown, nello stato di New York, che hanno studiato i geni codificanti per proteine in più di mezzo milione di persone inserite nell’UK Biobank. Ciò non significa che i meccanismi degli interferoni di tipo I non siano importanti, afferma Richards, che inoltre concorda che il collegamento con gli autoanticorpi sembra promettente.
Alessandra Renieri, genetista dell’Università di Siena e una dei primi membri di HGI, sostiene che, per permettere alla comunità scientifica di capire a fondo la suscettibilità a COVID-19 e di trovare terapie efficaci, i risultati degli studi GWAS debbano essere integrati con collegamenti alle varianti rare e ad altre forme di diversità genetica. Renieri fa parte di un gruppo di ricerca che ha richiesto alle autorità regolatrici italiane l’autorizzazione a sperimentare terapie basate sulle scoperte genetiche.
Per esempio, il gruppo intende sperimentare un adiuvante (che risveglia il sistema immunitario) in soggetti con mutazioni rare che inibiscono il gene TLR7, deputato al riconoscimento dei virus, il che potrebbe essere collegato alle forme gravi di COVID-19. Inoltre, dopo aver scoperto un legame tra COVID-19 grave e varianti genetiche associate a ridotti livelli di testosterone in circolazione nel sangue, il gruppo di ricerca intende valutare se il testosterone possa prevenire la forma potenzialmente letale di COVID-19 nei maschi che presentano una variante comune in un gene che codifica un recettore per quell’ormone.
Il successo di queste sperimentazioni non dovrebbe essere l’unico metro con cui valutare i frutti degli studi genetici su COVID-19, sostengono i ricercatori. Altri biologi si basano sugli studi genetici per capire i risultati dei propri esperimenti sul virus. E associazioni genetiche curiose come quella del cromosoma 3 potrebbero rivelare informazioni importanti che aiuteranno a curare COVID-19, ma anche la prossima malattia causata da un nuovo coronavirus, qualunque essa sia.
Ogni nuova scoperta genetica è come un pezzo di un puzzle, spiega Renieri. “Stiamo mettendo insieme diversi pezzi. Sono sicura che in un prossimo futuro la figura d’insieme sarà molto più chiara.”