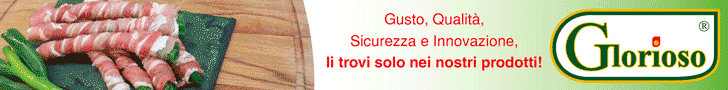Arrivo a L’Havana dopo un viaggio lungo e scomodo: quasi dodici ore seduto non su uno dei posti che danno sul corridoio – come io amo viaggiare -, ma tra due donne cubane, entrambe sposate con due italiani. La più giovane, sui trent’anni, con un napoletano, l’altra sulla cinquantina con un toscano. L’unico vantaggio di questa “prigione” forzata, oltre a quello di godere della compagnia di due belle signore particolarmente loquaci, è quello di ottenere una montagna di informazioni e di consigli che penso mi saranno utili nell’avventura che mi accingo a vivere.
Dopo l’atterraggio, sottolineato dall’applauso di gran parte dei passeggeri, prendo un taxi trattando sulla tariffa, così come mi aveva suggerito Mercedes, la napoletana acquisita. Lungo il tragitto, che dall’aeroporto conduce al centro della città vecchia, resto colpito dalle tantissime macchine che sfrecciano veloci a dispetto dei limiti di velocità, gran parte delle quali vecchie Fiat 124 (ma qui portano attaccato sul muso il logo della Lada, un marchio di origine sovietica) e qualche vecchia Chevrolet anni Cinquanta trasformata in taxi. A differenza dei nostri centri urbani sempre addobbati di luci sfavillanti, L’Havana mi appare con una illuminazione fioca, resa ancora più timida dai vetri oscurati della macchina, un debole luccichio che non induce all’allegria ma alla tristezza. L’albergo non è quello che mi aspettavo: il loro tre stelle si avvicina a stento al nostro due stelle, ma per non tradire i miei trascorsi “rivoluzionari“ mi sono detto: questo passa il convento, quindi come suol dirsi bisogna fare di necessità virtù. Faccio fatica a prendere sonno. Dopo un’ora abbondante di girarmi e rigirarmi nel letto finalmente ci riesco. Ma a rapirmi dalle grinfie di Orfeo provvede un crepitio assordante, mi alzo, guardo fuori dalla minuscola finestra del bagno e vedo una pioggia greve e fitta che riga la notte dell’Havana.
La capitale cubana ha poco di quello che caratterizza le nostre città: non ci sono negozi di lusso e grandi griffe a mostrare abiti e accessori alla moda (solo in qualche albergo di lusso si trova qualcosa); non c’è il traffico caotico, affollato di SUV e macchine di grosse e medie cilindrate che girano nervosamente alla ricerca di un parcheggio e quando non lo trovano le lasciano in doppia e tripla fila. Qui c’è un parco veicolare assai vetusto, fatto di vecchissime Cadillac e Chevrolet decappottabili che portano in giro per la città i turisti più danarosi e in più, appunto, vecchie Lada e qualche Pegeout. Di Alfa Romeo, BMW, Mercedes se ne vede qualcuna, ma solo a ogni morte di papa. Uscito dell’albergo per andare a fare colazione percorro (tra due ali di artisti che mostrano ai potenziali acquirenti le loro opere: tele e disegni che ritraggono rivoluzionari e paesaggi, oggetti in rame e cuoio) il Paseo del Prado, noto anche come “l’Alameda de Extramuros“. Un vialone alberato fatto costruire dal capitan General Marques de la Torre, nel 1772, che dal Capitolio (un edificio imponente sede dell’Assemblea nazionale del popolo) porta al mare.
Arrivo al Cafè El Louvre dove faccio colazione in compagnia di tre passerotti che si cibano degli avanzi caduti per terra. Lascio la grande piazza del Capitolio e mi tuffo, senza una meta precisa, nelle viscere di uno dei barrios della città vecchia. Resto particolarmente colpito da tre, quattro cose: dalle strade dissestate che fanno fatica – come a Catania – a far defluire la gran quantità di acqua caduta nella notte; le case sbrecciate e pericolanti che mostrano nel corpo tutti i segni del tempo; i tanti cartelli attaccati davanti alle abitazioni con su scritto se vende esta casa. Ma quello che mi incuriosisce maggiormente è la straordinaria umanità che incontro saltellando da una pozzanghera o da una buca all’altra. Una umanità fatta di ragazze e ragazzi che sprigionano allegria, vestiti come i nostri figli in jeans e maglietta; di donne con il culo grosso e il ventre un po’ sfatto dalle gravidanze che sgridano o coccolano i loro bambini; di vecchi in calzoni corti e in canottiera che tracannano bevande colorate, mostrando gambe e braccia flaccide, molli.
Niente a che vedere con la tristezza che leggevo nei volti dei russi e dei tedeschi dell’Est; né con il movimento frenetico delle genti di Pechino; o con gli sguardi allucinati e le facce disfatte dalla stanchezza dei giapponesi al ritorno dal lavoro, che a Tokio mi frastornarono non poco. La mattina successiva, prima di andare a fare colazione al solito caffè, attraversando El Paseo del Prado, orfano degli artisti del giorno prima, mi imbatto in un gruppo di ragazzini seduti a cerchio per terra che ridono e gridano a squarcia gola mentre giocano a girare tutti intorno al mondo. E così, prima di proseguire la mia avventura per Vinales, una importante metà turistica, patrimonio culturale dell’umanità, mi rivedo bambino con Totò, Cono, Silvio, Gino e Concetto; con Nicola, Filippo, Mariano e tanti altri (alcuni purtroppo passati a miglior vita, altri emigrati in terre lontane a cercare fortuna, pochi quelli rimasti in Sicilia a lavorare la terra o ad esercitare una professione ), seduti a cerchio a giocare e a girare tutti intorno al mondo.
A Vinales la donna che mi accoglie nella casa famiglia che mi ospiterà – desiderosa di farmi sapere subito come la pensa – alle mie prime domande sulle condizioni del Paese, risponde senza alcuna remora che “a Cuba tutto è cambiato, una sola cosa non è cambiata…“. E continua il suo dire mentre il marito, un medico generico che lavora nell’ambulatorio del distretto, aspetta sornione per dire la sua. Quindi nelle prossime puntate vi dirò cosa non è cambiato, e se quello che è cambiato è cambiato in meglio o in peggio.
Fine della prima parte