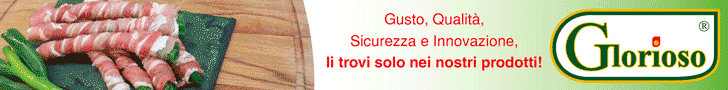Il rapporto sulla competitività del settore agroalimentare, presentato qualche giorno fa a Roma nella sede dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), contiene delle novità di assoluto rilievo.
Relativamente al 2017 le novità più significative sono: l’incidenza del settore nella formazione del Prodotto Interno Lordo che ha raggiunto il 13,5% in valori percentuali e 219,5 miliardi di euro in valori assoluti, con un valore aggiunto pari a 60,4 miliardi di euro; il record fatto registrato lo scorso anno dall’export – in particolare delle produzioni tipiche del Made in Italy, vino e prodotti trasformati ad alto valore aggiunto – che ha superato i 41 miliardi di euro (in 5 anni è cresciuto del 23%, mentre nel resto d’Europa si è fermato al 16 %); l’incremento dell’occupazione che nell’ultimo quinquennio è aumentata del 3,3%; e, infine, il miglioramento del saldo tra esportazioni ed importazioni che è sceso da -7,3 miliardi a -4 miliardi di euro.
Dai dati anzidetti si evince che il settore agroalimentare durante la crisi ha mostrato una grande tenuta economica e sociale, superiore a quella degli altri comparti produttivi, nonché una buona capacità di ripartenza.
L’Italia grazie a queste performance, ha 800.000 imprese e ha 1.385.000 addetti, di cui 913.000 impegnati in agricoltura e 465.000 nell’industria di trasformazione e dimostra di essere ancora uno dei paesi più agricoli tra gli Stati d ‘Europa.
Ciò nonostante in questi anni gli investimenti siano diminuiti del 32%; l’acquisizione dei terreni agricoli abbia raggiunto un costo notevolmente maggiore rispetto a quello di altri Paesi (sei volte in più della Francia e tre volte in più della Spagna); e mentre i nostri competitor non sono rimasti con le mani in mano. Anzi, per fare solo qualche esempio, gli altri Paesi che ci contendono il mercato hanno migliorato le loro performance sia nel campo dell’innovazione tecnologica, sia nelle infrastrutture al sevizio del settore, utilizzando a questo fine le risorse europee, cosa che noi, invece, non abbiamo saputo fare.
Ma è tutto oro quello che luccica? Assolutamente no!
Infatti se facciamo i conti in tasca agli agricoltori – cosa sempre sgradevole – scopriamo che su 100 euro di spesa in prodotti freschi solo 22 euro arrivano ai produttori. Tolti gli ammortamenti e le spese per i salari, l’utile per l’imprenditore agricolo si riduce a 6,3 euro. La situazione peggiora ulteriormente per i prodotti trasformati: su 100 euro spesi dal consumatore, agli agricoltori vanno 6 euro e 9 euro all’industria alimentare che, sottratti gli ammortamenti e le spese per i salari dei dipendenti, si riducono a 1,8 euro per l’agricolture e 1,6 euro per l’imprenditore della trasformazione.
Quindi, a totalizzare margini di guadagno di gran lunga superiori all’interno della filiera sono la grande distribuzione e, in misura minore, la logistica.
È vero il Bel Paese e in particolare il Sud ha un potenziale enorme, rappresentato dalle denominazioni registrate (quasi il 30 % a livello mondiale sono italiane), dalla crescita del bio, dalla qualità, dalla passione, dalla storia e dalla tradizione che rendono unico il Made in Italy agroalimentare nel mondo.
È vero anche, come è stato sottolineato nel corso della presentazione del Rapporto, che c’è un nuovo approccio al cibo “che è considerato sempre meno un puro alimento per soddisfare esigenze caloriche e sempre più occasione di consumo differenziato, per appagare bisogni più complessi ,come qualità ,tipicità esperienza culturale”.
Ma in un contesto caratterizzato dalla crisi del vecchio modello di globalizzazione, dalla guerra dei dazi tra USA e Cina, dagli embarghi tra Europa e Russia e dal gap di tecnologia e infrastrutture al servizio del settore esistente tra Germania, Spagna e Francia, le prospettive non appaiono rosee per l’agroalimentare italiano.
Come ho già accennato, capovolgere questa prospettiva negativa è possibile, a condizione però che si remi tutti dalla stessa parte (istituzioni, partiti, forze imprenditoriali e sociali). E remare nella stessa direzione vuol dire: ridiscutere gli accordi stipulati in sede europea, perché il Paese più agricolo d’Europa non può avere una politica comunitaria che lo danneggi; utilizzare tempestivamente i fondi europei, puntando maggiormente sul cervello e sulla tecnologia; assicurare al settore un più agevole accesso al credito; ridurre i costi del lavoro; garantire ai produttori agricoli una giusta remunerazione perché, attualmente, sono quelli che pagano il conto più salato, a causa degli squilibri di filiera.